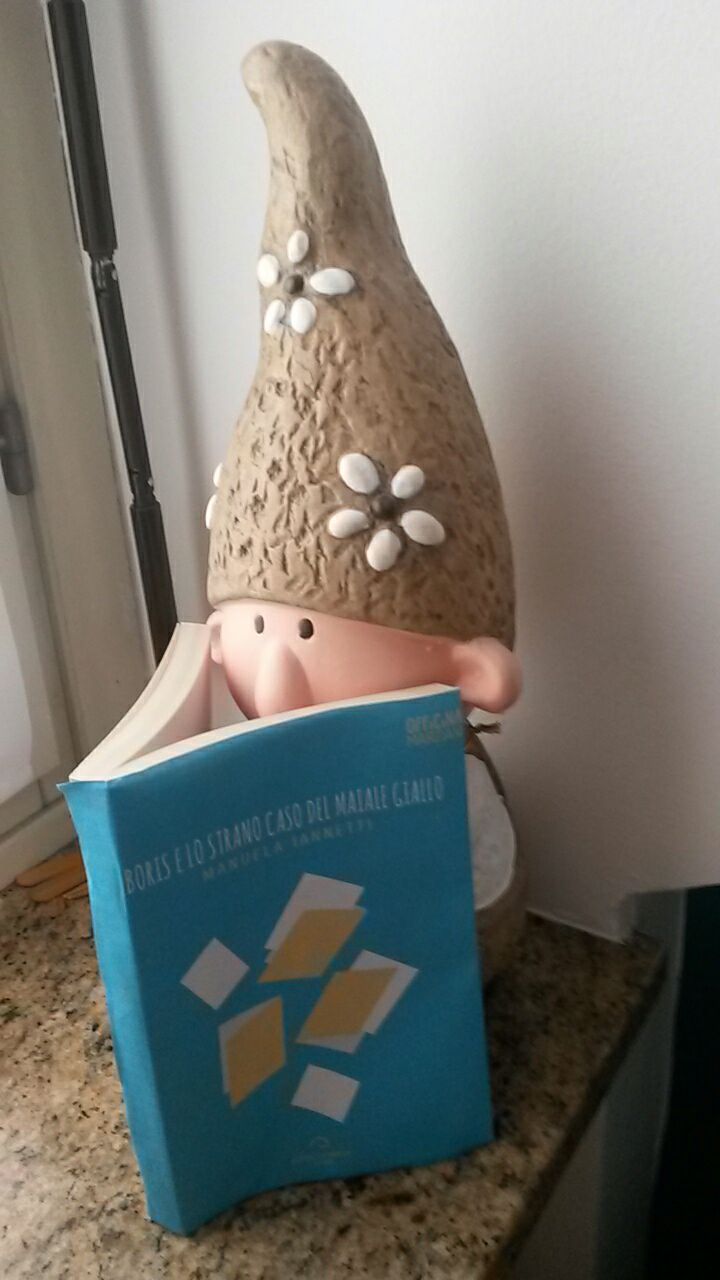Arbain Bin Kadirun è l’Imam del villaggio di Patu Puteh, nella regione del Kinabatangan, nello stato di Sabah. Vive nel cuore del Borneo malese, a 150 km dalla città più vicina, che si chiama Sandakan ed è forse una delle più brutte al mondo. Per arrivare a casa sua ci vogliono almeno 19 ore, 3 aerei e un paio d’ore di pullman. Almeno, questo è stato il tempo che ho impiegato, tappe intermedie comprese, per essere ospite a casa sua.
Arbain vive con sua moglie, due figlie femmine e un figlio maschio. Prima c’era anche la nonna, ma è scomparsa da poco. Lo ricostruisco io, mettendo insieme i pezzi del puzzle planisferico che ho sotto gli occhi mentre sbircio dentro la sua casa. C’è un ritratto di famiglia, con la nonna presente, la stessa nonna che la figlia più piccola mi mostra in un filmato registrato sul cellulare. Devo dire una nonna non in salute, accolta in un letto d’ospedale da tubi e tubicini. Ma la bimba sembra contenta, nel ricordala. Lo intuisco, perché io non parlo malese, e nemmeno uno dei dialetti dei discendenti degli Iban ancora presenti in queste terre, né tantomeno cinese o tamil. Per cui ci aggiustiamo a gesti e a sorrisi, che ci si capisce benissimo lo stesso.
Arbain e sua moglie K. hanno aderito al programma della comunità Mescot, che ospita persone desiderose di percorrere 11mila chilometri per andare a piantare alberi nelle foreste liberate dalle piantagioni latifondiste delle multinazionali, come me e le mie amiche. Una cosa, quella di piantare gli alberi, che facciamo solo noi stranieri a quanto ci spiegano in seguito, ma che fa tanto bene alle persone del posto che così prendono esempio. Così ci dicono, ma non Arbain, che è una persona gentile.
Arbain non c’è mai, o quasi mai, in casa. Essendo l’Imam, guida la comunità del villaggio e si reca diverse volte durante la giornata presso la moschea. Il Villaggio Batu Puteh è musulmano, ma questa è solo una delle varie possibilità religiose dell’isola. Nei giorni precedenti, in un’altra parte sperduta di questa foresta immensa che è il Borneo, nello Stato di Sarawak, ad accoglierci era stato invece un villaggio cristiano di discendenti degli Iban.
I tagliatori di teste, per intenderci.
Discendenti cristiani di tagliatori di teste, per capirci. Che ci avevano accolto con una testa di maiale arrostito e grappa di riso in bottiglie di plastica.
Per intenderci.
Il villaggio di Arbain invece è un’oasi di serenità. Arbain e sua moglie, come tutti i vicini, vivono in baracche di legno leggermente sollevate da terra, Homestay essenziali, con tetti di lamiera e grossi cilindri fuori da casa con un rubinetto corrente a fungere da doccia e ristoro.
La cucina della casa di Arbain è a vista, nel senso che è all’aperto, e si vede la foresta che sta tutt’intorno al villaggio. Sua moglie K. di giorno si inerpica dentro il fogliame e se ne torna con ceste piene di “erbe della foresta”, specie di costine ricurve con ghirigori arabeggianti che sono squisite e verdissime.
K. ha preso sul serio il compito dell’accoglienza, e ci ha preparato un pranzo di benvenuto, a base di riso, frutta, spezzatino di carne, ciambelle. Non mangiamo tutti insieme però; solo io, la mia compagna di ventura V., la signora K. e una delle bambine, quella che è riuscita con fatica a sottrarre al gioco esattamente come qualunque mamma italiana nei pomeriggi d’estate.
Selamat Datang, benvenute, ci dice K.
Arbain arriva questa sera, dice ancora, in un inglese ancora più acerbo del mio, che me la rende subito simpatica. Dopo pranzo abbiamo tempo per riposarci nella camera che ci hanno riservato. Dato che non c’è posto a sufficienza, hanno fatto che darci il loro letto nuziale. A nulla valgono le nostre proteste: dormiranno tutti insieme in una stanza, per terra o sui cuscini, che l’ospite è sacro.
La stanza da letto è una stanza come tutte le altre nella casa, solo con un letto. Come le altre nel senso che non ci sono altri oggetti, soprammobili, tappeti o sedie. Solo un buco nel pavimento da cui entrano formiche copiose, una finestra sul retro del cortile dove una capra si lagna alternandosi al gallo del cortile vicino e una lampadina che però si può accendere solo in alcuni orari, perché di notte il generatore si spegne per risparmiare energia. E con esso anche i ventilatori, l’acqua corrente del bagno, la luce della casa.
Arbain ha un grande Corano posto in bella mostra nella stanza principale. È bellissimo, tutto decorato e miniato. A fianco del Corano c’è il mobiletto della tv, accesa notte e giorno. Sua moglie guarda una specie di telenovela sdraiata sul legno del pavimento, che mobili non ce ne sono, appunto.
Dopo la siesta K. ci insegna a cucinare un paio di piatti locali. Usiamo olio di palma, verdure, riso e condimenti a base di peperoncino. Mi appunto la ricetta della torta di banane, e mi impegno a inventarmi una ricetta da regalarle perché possa riprodurla qui per la sua famiglia.
Non me ne vengono. Non abbiamo gli stessi ingredienti, non esiste forno, è un pasticcio. Ci penserò a casa, con calma, e prendo tempo cercando di non far scuocere le verdure scottate. Usiamo sempre la stessa pentola, sciacquata velocemente con un po’ d’acqua gettata poi dalla finestra sulla foresta, in spregio alle regole base della vita green. Mi vengono in mente le parole sugli alberi da piantare e forse capisco meglio cosa volessero dirci, stamattina.
A un certo punto K. ci dice che siamo in ritardo e che dobbiamo andare. Lasciamo il pasto in caldo, e ci avviamo con lei verso l’uscita della casa. Ci rimettiamo le scarpe, che avevamo lasciato fuori sui gradini di legno, e la seguiamo verso il centro del villaggio.
Da lontano, vediamo nugoli di persone convergere verso lo stesso punto, tutti allegri.
Io temo che sia il momento della preghiera corale, invece è il momento della socializzazione.
Sport, per la precisione.
Volley su selciato, per la precisione.
Con mio grande stupore, tutto il villaggio si ferma.
La rete da pallavolo si staglia tutta ondulante sotto il Kinabatangan Bridge. Le squadre vanno formandosi tra i convenuti. Donne, uomini, bambini, ragazzi, ragazze, velate, senza velo, tutti scalzi, tutti felici. Ci sono molti ragazzi omosessuali, lo noto perché è impossibile non notarlo. Ma non è no sguardo pruriginoso, ma di stupore felice. Che siano dichiarati o meno non mi è dato saperlo ma nessuno, in questo sgarrupato villaggio musulmano baraccato sotto il ponte, sembra curarsi dell’orientamento sessuale di chicchessia, e tutti giocano con tutti.
Ci chiedono se vogliamo far parte di una squadra. Intanto sono sopraggiunte anche le altre due compagne di viaggio, dislocate presso un’altra famiglia. Ci sediamo vicine sull’asfalto caldo, tra bimbi in bicicletta, cani a zonzo e caprette.
Io farfuglio qualcosa, la schiena, la stanchezza… in realtà vorrei giocare, ma la tentazione di assistere a questa scena insolita e pacifica come osservatrice ai bordi della vita degli altri alla fine vince su tutto.
Osservo le persone, i loro sguardi, i loro gesti. Mi sembra che in questo villaggio ci sia una regola implicita di rispetto e spazio, di tolleranza e inclusione. Di attenzione per i singoli, per i diversi.
A partire da noi.
Quando rientriamo in casa inizia a piovere. Una pioggia ostinata e battente, una pioggia di acqua che si insinua tra case e strade, nelle scarpe lasciate fuori dagli usci, sulle galline che protestano, sulle lamiere, sul legno che respira.
Ceniamo con i piccolini, che ci guardano con curiosità e occhi sgranati. Ci offriamo per risistemare la cucina dopo il pasto, ma in realtà c’è poco da riassestare: le stoviglie sono contate, i bicchieri pure, il contenuto delle pentole finisce dove già so, e tutto finisce lì nell’acquiescenza generale.
Così quando la piccola ci prende per mano per portarci sulla terrazza, finiamo per seguirla senza sensi di colpa.
Fuori inizia a scrosciare pioggia con una certa violenza, la luce del giorno è calata del tutto. Illuminati da una lampadina, i nostri corpi disegnano ombre sul pavimento di legno e linoleum.
Giochiamo a Congkak, o Sungka, o Mancala, come si chiama rispettivamente in Malesia, Filippine o in tutta l’Africa.
Non abbiamo pedine, né conchiglie da usare, o semi, per cui la più piccola si mette scarpe e mantellina ed esce sotto il diluvio tropicale per recuperare dei sassolini abbastanza grandi e abbastanza numerosi per poter giocare. Inutile dire che in breve siamo stracciate. Non riusciamo a piazzare nemmeno una partita, la piccola ci sconfigge da esperta stratega. La base in legno grezzo su cui posiamo le pietre viene spazzata dalle sue manine veloci, guidate da intuito e visione d’insieme.
Capiamo che i principi generali sono la semina e la raccolta, conditi da un certo ingegno previsionale rispetto a dove capiterà l’ultimo sassolino del raccolto che si muove sul tavolo da gioco durante la semina. Mentre la guardiamo, ammirate, decidiamo all’unisono che al nostro rientro le invieremo una scacchiera con tanto di istruzioni tradotte. In lei c’è un futuro da srotolare e far risplendere. Che sia da militare o da giocatrice poco importa: la sua mente richiede ammirazione e spazio.
Lo stupore che mi toglie il fiato arriva però subito dopo. La più grande delle due bambine prende da parte 5 sassolini levigati e grossi quanto i noccioli delle nespole, li soppesa nel palmo della mano lentamente, con fare sapiente, e poi si volta verso di me, sorridendomi.
Non posso credere ai miei occhi: mi sta sfidando a giocare “alle 5 pietre”!
Il gioco della strada, il gioco dell’infanzia, il gioco dei bambini di ogni parte del mondo, il gioco che unisce generazioni e ricordi, ingegno e povertà. Il gioco fatto di niente, senza guantoni o divise, il gioco democratico insegnatomi da mio padre mille e mille estati fa, in una stessa sera di pioggia estiva, sotto la luce di un’altra lampadina precaria nell’infanzia montana di cui serbo ricordi fatti di odori umidi e bruni come la pioggia d’estate, pensieri caldi e bianchi come l’afa agostana, gesti familiari e verdi come le nocciole spezzate con la pietra sul tavolo di quercia.
Penso a mio padre e sorrido. E mentre sorrido arraffo le pietre e le lancio sul linoleum, con la sfida negli occhi. Le bimbe si contorcono gioiose per le risate.
Quando Arbaein torna, è ora di andare a letto. Le figlie si accomiatano dandoci un bacio e regalandoci un sorriso che si incunea tra la pelle e il cuore.
Arbain si siede con noi in terrazza, si accende una sigaretta.
Parliamo un po’? ci chiede.
Poi inizia a raccontare. In un ottimo inglese ci narra la sua vita, ci descrive la sua famiglia, le tradizioni del suo popolo, il loro cibo, la natura che li circonda. Per fortuna V., che abita con me, conosce benissimo la lingua dell’impero, e io mi accoccolo dentro il suono delle loro parole, cogliendo il senso generale della discussione su petrolio e inquinamento, su geopolitica e natura.
A un tratto ci domanda del nostro paese, della nostra città, delle nostre vite.
Sorride curioso e ride a crepapelle quando scopre che da noi no, non abbiamo davvero scimmie sugli alberi, e che sì le banane le importiamo. Ci chiede quale sia l’animale tipico da noi, e con non poca esitazione risolviamo che orso, gatto e lupo possano andare bene, che già a descriverli è una fatica dialettica e immaginifica.
Arbain dice che i suoi figli vanno a scuola da soli, ogni mattina. Camminano per due chilometri, poi un pulmino viene a recuperarli. Hanno tutti una divisa pulita e ordinata. Blu e bianca. Le bambine, che io ho visto scorrazzare in casa in pigiama e per il villaggio con pantaloncini e maglietta, vanno a scuola con il velo. Sua moglie il velo non lo porta, però nelle foto di circostanza sì. Sono un po’ confusa, ma poi penso che ho appena descritto il mio paese come infestato da belve feroci ad ogni angolo di strada, per cui taccio sulle stranezze altrui e sulla lingua.
Solo una cosa mi infastidisce.
Quando mi domanda se la nostra città è proprio quella della Juventus (lo chiede molto speranzoso, sottolineando la parola Juventus con gli occhi).
Non me ne capacito. E non è perché io sono di Torino e tifo Toro, no no. Forse è perché qui non esiste la tirannia del calcio e i bambini tirano a canestro o sopra la rete con la stessa gioia nostrana davanti alla palla che rotola, per cui mi suona strano parlare di calcio, nella notte che cade liquida sotto il ponte di ferro arruginito. Ok, va bene, è perché sono del Toro.
Comunque Arbain mi sta simpatico lo stesso.
A un tratto smette di piovere.
Arbain si accomiata: questa notte alle 5 ci sarà la preghiera, e lui dovrà presenziare in moschea. Ci salutiamo con un cenno della mano, dandoci appuntamento per il commiato vero, che sarà nel pomeriggio del giorno che verrà.
Piano, dentro di me, sento farsi strada nel cuore la nostalgia degli incontri, la malinconia delle cose belle appena trascorse che mi accompagnerà da domani in poi.
Da dentro casa avvertiamo il suono soffuso della televisione, e un leggero russare. Suoni domestici, familiari, noti.
Ci alziamo lentamente. Poco lontano, il lungo fiume Kinabatangan dorme placido e giallo.
Trimacase, diciamo in coro, abbassando leggermente il capo.
Grazie.